L’età di Michael Jordan
19 Giugno 2024
di Roberto Gotta

Introduzione del libro ‘L’età di Michael Jordan’, di Roberto Gotta, pubblicato da Indiscreto nel giugno 2024 e in vendita su Amazon, sia in versione cartacea sia in versione Kindle, sulle altre librerie online e in tante librerie fisiche in tutta Italia, dalla Hoepli a chiunque ne abbia fatto richiesta al nostro distibutore, Distribook
INTRODUZIONE
Stavo guardando l’angosciante vuoto di questa pagina, nel pomeriggio dell’11 maggio 2023, quando per un attimo ho distolto lo sguardo dal computer e l’ho girato verso il televisore. Era finito da poco il match degli Internazionali d’Italia di tennis tra Lorenzo Sonego e Jeremy Chardy e sul commento dallo studio stavano passando immagini della partita. Sul punto decisivo, con Sonego al servizio, l’inquadratura ha mostrato sullo sfondo una ragazzina con una maglietta bianca Jordan Brand. Pochi istanti dopo, mentre il tennista italiano riceveva da una hostess la torta per il ventottesimo compleanno, la regia ha scelto di mostrare un cartello di auguri alzato da un ragazzino con un cappello Jordan Brand. Un caso, ovviamente, che però mi ha fatto venire in mente che forse nessuno dei due giovanissimi sapeva chi fosse il creatore della marca che indossava. E come tutto questo fosse comunque irrilevante. Perché Jordan Brand è una creatura a sé stante, che ormai prescinde dallo status del suo ispiratore, Michael Jordan, oltre venti anni dopo il suo definitivo ritiro dal basket giocato.
Perché siamo nell’età di Jordan, sì. Nel senso dei 60 anni compiuti il 17 febbraio del 2023 e nel senso, molto più ampio, di era e periodo, iniziati probabilmente il 29 marzo 1982, con il tiro della vittoria per North Carolina contro Georgetown. Alla partita era presente Sonny Vaccaro, figura di cerniera tra il basket liceale e quello universitario, che di fronte a quel tiro, a quella determinazione e a quell’innocente carisma ebbe una rivelazione. Due anni dopo, su ispirazione di Vaccaro e con il contributo di altre figure importanti, Jordan diventò il volto della Nike e partì, senza nemmeno rendersene conto, per la conquista del mondo. Non è un’esagerazione: dai primi anni Novanta Jordan è uno degli esseri umani più famosi sul pianeta e il suo nome, quello delle sue scarpe e quello della sua linea, Jordan Brand, appunto, sono conosciuti anche da chi non lo ha mai visto giocare. Nel libro del 1999 che ha costituito la robusta base di questo, Oh, Michael, riportavo la curiosità dell’anziano custode del remotissimo, favoloso sito maya di Yaxchilàn, nella Selva Lacandona tra Guatemala e Messico, che nell’estate del 1996, vedendomi gettare con fortunosa precisione lo zaino su un soppalco destinato a custodire bagagli ingombranti, urlò festante “Canasta de Màicol Iordan!”. Canestro di Michael Jordan. La netta sensazione, allora, di una notorietà che era davvero arrivata ovunque, e che nel tempo si è addirittura allargata.
In questo libro, a oltre venti anni da Oh, Michael, ripercorro la sua carriera evidenziando soprattutto le tappe che lo hanno portato ad essere un mito dei tempi moderni, mito che si è ravvivato nella tarda primavera del 2020 quando lo stesso Jordan, dopo aver atteso a lungo, ha approvato la pubblicazione di The Last Dance, il documentario sulla sua ultima stagione ai Chicago Bulls, la 1997-98. Un periodo che, con la pandemia e le limitazioni alla libertà personale che hanno costretto tanta gente a rimanere in casa, ha permesso ad un pubblico enorme di accedere al canale in streaming in cui lo speciale andava in onda. E fu una grande soddisfazione per me, alcuni mesi dopo, sentirmi dire da un giovane collega «Ma lo sai che The Last Dance me lo sono goduto meno perché gran parte degli episodi li avevo letti nel tuo libro?». In effetti Oh, Michael era ricco di fatti e aneddoti ed era nato anche per la benevolenza dell’editore dell’epoca, la Cantelli Editore, che pubblicava Superbasket e American Superbasket: mi fu consentito di andare a Wilmington, nel North Carolina, città importante e tormentata, come leggerete, e di scavare nell’archivio del locale museo, nel quale – a dire della direttrice – non era mai andato nessun giornalista. Non potei che pubblicare una parte della documentazione, ma quel viaggio, nel quale visitai i luoghi frequentati dal Jordan adolescente, il suo liceo, la sua casa e, tornando verso l’aeroporto, la University of North Carolina, mi permise di raccontare con una prospettiva diversa, un pochino vissuta. Prospettiva a cui ho poi aggiunto le emozioni che portavo con me dalle volte in cui avevo visto Jordan giocare dal vivo.
La prima era stata a Miami, in un’atmosfera da guerriglia urbana. Era il 19 gennaio 1989. Prima stagione nella storia dei Miami Heat e prima visita dei Chicago Bulls alla Miami Arena, un impianto completato pochi mesi prima in una delle tante brutte zone della città, uno dei tanti angoli di metropoli americana in cui arrivi, parcheggi, entri ed esci più in fretta che puoi per evitare guai. Qualche giorno prima Miami-Phoenix era stata rinviata per motivi di sicurezza: Overtown e Liberty City, i due quartieri adiacenti all’arena, erano stati l’epicentro di violentissimi disordini scoppiati dopo l’uccisione di un ragazzo afroamericano, Clement Lloyd, da parte di un poliziotto ispanico, William Lozano. Questo in una città dove gli afroamericani erano poco alla volta stati superati anche numericamente dai centro e sudamericani sul mercato del lavoro e dunque si erano create tensioni immense. Non bisogna dimenticare che tra l’aprile e il settembre del 1980 erano arrivati a Miami circa 135.000 cubani, lasciati andare da Fidel Castro che, già che c’era, aveva fatto imbarcare anche un buon numero di pregiudicati: le stime vanno dai 2.500 ai 20.000, considerando che in alcuni casi i crimini commessi erano stati ritenuti gravi a Cuba ma non sarebbero nemmeno stati puniti con l’arresto negli Stati Uniti. Il film Scarface racconta, con le solite esagerazioni cinematografiche, la parte peggiore di tutto ciò, ovvero l’impatto dei criminali sulla città. Ma le difficoltà normali erano state proprio l’assorbimento di un numero così grande di persone nel mondo del lavoro, il loro formare immediatamente un nucleo a parte, ricongiunto magari ai parenti scappati o approdati anni prima, e una serie di conseguenze nella vita di tutti i giorni, compresa l’ostilità di molti residenti, di tutte le etnie, verso i nuovi arrivati. Ecco perché la reazione all’uccisione di Lloyd fu così violenta, con tanto di rivoltosi a sparare dai tetti e assalti a persone colpevoli solo di essere passate nel momento sbagliato, nel posto sbagliato e di avere il colore della pelle sbagliato, che facesse cioé pensare a origini europee o latinoamericane.
Comprensibile che fosse stata rinviata Miami-Phoenix, ma due giorni dopo la situazione era tornata parzialmente gestibile e così si diede il via libera a Heat-Bulls, forse anche per non rovinare la vigilia del Super Bowl, previsto di lì a tre giorni. Una serata davvero memorabile, la prima apparizione a Miami di quello che stava diventando il giocatore più famoso della NBA e però ancora alla ricerca del primo titolo. L’atmosfera ricordava un po’ quella descritta poco tempo prima da Johnny Cash nel suo brano The night Hank Williams came to town, che racconta in poche, efficacissime strofe il primo, attesissimo concerto di Williams, una delle prime superstar della musica americana, in una città di provincia. La trepidazione, i residenti che poco alla volta escono di casa, la prima puntata di una serie televisiva che stavolta nessuno vede, il fremito nei minuti che precedono l’ingresso, il bisbiglio che diventa emozione nel momento in cui l’artista, il protagonista, entra in scena. Jordan a Miami era peraltro, in teoria, un avversario, ma l’effetto fu lo stesso: occhi solo per lui, flash delle macchine fotografiche solo per lui, mormorii ad ogni pallone ricevuto, ovazioni ad ogni canestro, passaggio, schiacciata, gesto. Ero seduto a bordo parquet, lungo la linea di fondo, con un accredito da fotografo, l’unico disponibile. Ho tuttora il video e le foto fatte in quella occasione, compreso un primo piano in spogliatoio che va annoverato tra le involontarie rarità: all’epoca era ancora possibile fare foto in luoghi come quello, prima che scattasse il divieto, revocato solo in occasioni pre-autorizzate e nei festeggiamenti per una vittoria. E MJ presto cominciò a cambiarsi in uno stanzino a parte, irritato dalla possibilità di essere fotografato o ripreso in un momento che considerava intimo.
Jordan l’ho poi rivisto giocare varie volte, e sempre a Chicago. Mi piaceva andare allo United Center perché la presentazione del quintetto iniziale dei Chicago Bulls resta a mio avviso la più straordinaria nella storia dello sport professionistico, e non solo perché tutte le altre che l’hanno seguita si sono dovute affidare ad effetti speciali, allargamenti in 3D, video di giocatori con sguardi torvi o pose B-boy (braccia conserte e testa lievemente di lato e all’indietro) da bulli di quartiere. Anche se al momento del passaggio nella nuova arena, lo United Center, gli stessi Bulls per creare una introduzione alla presentazione idearono un’animazione altrettanto emotiva, con una mandria di tori che attraversava la città confluendo poi allo United Center. Le immagini svanivano e sul crescendo della musica, Sirius degli Alan Parsons Project, curiosamente essa stessa una intro all’album Eye in the Sky, lo speaker in carica dal 1990, Ray Clay, ruggiva «Aaaand now, the starting lineup for your Chicago Bulls», procedendo all’elenco dei giocatori del quintetto. All’americana, ovvero le due ali, il centro e le due guardie. Man mano che i Bulls vincevano titoli veniva aggiornata la dicitura iniziale, partendo, dall’ottobre 1991, da «For your World Champions Chicago Bulls». Presentati i primi quattro, toccava a Jordan: «From North Carolina, 6’6, Michael Jordan». Da North Carolina, sei piedi e sei di statura , Michael Jordan. Peccato che già su ‘from’ il baccano salisse al punto da far sparire le parole successive: lo sapevano bene i responsabili marketing dei Bulls, che tra i consigli che diedero a Clay, dopo le prime partite di prova, aggiunsero «Non importa come pronuncerai il nome di Jordan, tanto non lo sentirà nessuno». Si chiudeva con la presentazione del coach, anch’essa a malapena udibile, creando un’atmosfera che poi, per assurdo, si dissolveva sulla palla a due e sulla prima azione di gioco, in cui persino dalle file alte si potevano sentire gli scricchiolii delle suole sul parquet. In attesa naturalmente che Jordan si attivasse a modo suo.
L’idea di Sirius era venuta a Tommy Edwards, deejay e speaker predecessore di Clay, su richiesta del reparto marketing della squadra che voleva celebrare in maniera adeguata l’arrivo di Jordan ai Bulls. Edwards, che per il grande successo come conduttore radiofonico fu poi trasferito a Los Angeles e si perse gli anni dei titoli, soffrendo per la distanza, già nel 1977 aveva avuto l’intuizione di far spegnere le luci prima dell’annuncio dei nomi di una partita molto importante, creando quindi già un’atmosfera particolare, poi aveva sperimentato varie basi musicali, dalla sigla di Miami Vice (1984), a Thriller di Michael Jackson (1982), ma un giorno, al cinema, aveva ascoltato e riconosciuto Sirius che veniva usata come sottofondo prima del film e gli era venuta l’illuminazione. Si era comprato Eye in the sky e, a casa, aveva cominciato ad allenarsi ad annunciare i giocatori nei momenti giusti. A conquistarlo erano stati l’attacco, il crescendo solenne, le pause dei singoli strumenti che consentivano il parlato senza coprire nulla di cruciale. Ai giocatori, e a Jordan, Sirius era piaciuta immediatamente e con i titoli vinti diventò forse la musica specifica più famosa d’America, allargandosi anche – senza il medesimo effetto – ad altre squadre come Utah e San Antonio e persino al team francese di Coppa Davis del 2014 e alle celebrazioni di tanti matrimoni. Personalmente ho tuttora la pelle d’oca ad ascoltarla, come ho fatto più volte durante la scrittura di questo libro, e la metto assieme al ballett di Ray Lewis, linebacker dei Baltimore Ravens due volte campioni NFL, come pre-partita più stupefacente e sconvolgente della storia, due esempi di musica (nel primo caso) e movenze (Lewis) che mi darebbero una carica tale da indurmi a scendere in campo senza indugi e senza paura, persino alla mia età.
Sempre allo United Center, in una delle ultime visite, nel 1998, cercando di farmi coraggio andai dal centro Bill Wennington, che conoscevo dai tempi della Virtus Bologna (1991-93), con una busta, già preaffrancata e con il mio indirizzo di casa, contenente una canotta numero 23 e una foto di Jordan: chiesi a Bill se potesse essere così gentile da farle firmare a Michael. Una volta raggiunto lo scopo avrebbe semplicemente dovuto metterle in una buca della posta, o darla ad un fattorino dei Bulls perché facesse altrettanto. Alcune settimane dopo la busta mi arrivò, stranamente leggera: la foto, autografata, c’era, ma della canotta nessuna traccia, e mi sono sempre chiesto se negli uffici dei Bulls non l’avessero mai inserita o se qualcuno – ma è improbabile, visto che il contenuto non era annunciato – l’avesse sottratta richiudendo poi il pacchetto.
L’ultima volta in cui ho visto Jordan è stata alla conferenza stampa in cui venne annunciata la sua elezione nella Hall of Fame, aprile 2009. Era la mattina della finale NCAA tra la ‘sua’ North Carolina, allenata dal vecchio amico Roy Williams, e Michigan State, a Detroit, e pur di non perdermi l’appuntamento avevo fatto una tirata notturna in corriera, linea Greyhound, da Toronto, dove la sera prima avevo cenato con Andrea Bargnani, un incontro organizzato dallo sponsor del giocatore romano. Surreale la scena di un giocatore NBA che, col suo SUV, accompagna un giornalista italiano alla modestissima stazione delle corriere, ma tant’è: prendere un volo il mattino successivo, anche all’alba, avrebbe voluto dire perdersi Jordan. Che quel giorno, allo scontato annuncio della votazione favorevole, parve contemporaneamente felice e pensoso, come se si stesse chiedendo cosa avrebbe potuto fare nel resto della sua vita per continuare a vivere le emozioni che lo avevano portato fino a lì. Anche se in realtà, all’epoca, stava già meditando di acquisire la maggioranza delle azioni dei Charlotte Bobcats, di cui era socio da tre anni.
L’età di Jordan è questa. Un flusso, sportivo, agonistico, commerciale ininterrotto dal 1984, che è riuscito a sopravvivere a condizioni clamorosamente diverse da quelle iniziali e a imprimersi nell’immaginario di due, forse tre, generazioni di appassionati di sport, di basket, di abbigliamento sportivo, di cultura popolare americana e mondiale. Jordan è un personaggio che solo chi nel 2024 ha almeno 36 anni può dire di aver visto giocare in diretta, o dal vivo, e di aver compreso nella sua grandezza di giocatore. Il suo ritiro definitivo è avvenuto il 16 aprile 2003, al termine di un biennio con i Washington Wizards su cui è tuttora difficile dare un giudizio obiettivo, ma il Jordan vero, che ha dominato la scena del basket mondiale con la sua presenza, la sua cattiveria e la sua aggressività, è stato quello dei sei titoli vinti, 1991-93 e 1996-98. Qualcosa di mai visto prima e di irripetibile, non solo per le doti di MJ ma anche per il particolare momento storico e sociale nel quale si è affermato: un’America che dal 1980, con l’elezione di Ronald Reagan entrato poi in carica nel 1981, aveva ripreso consapevolezza di se stessa come guida dell’Occidente, meno disposta all’autoflagellazione rispetto al periodo della disastrosa guerra in Vietnam, e in cui la spinta all’affermazione di sé e del proprio diritto alla felicità, sancito dalla Dichiarazione di Indipendenza del 1776, aveva ripreso vigore, così come il concetto di eccezionalismo, enunciato per la prima volta da Tocqueville nel 1831. Abbinato a quello, simile, di ‘destino manifesto’ (traduzione abituale ma zoppicante, preferisco ‘destino evidente, palese’), cioé la convinzione che gli Stati Uniti avessero (abbiano) la missione para-divina di diffondere progresso e democrazia nel mondo. Fa un po’ ridere tutto ciò, alla luce di quanto succede ogni giorno e della catastrofica diffusione del politicamente corretto, nato proprio lì e destinato ad abbattere l’Occidente, ma questa era l’enunciazione.
Era un’America dai mille difetti, ora diventati centomila, alcuni dei quali ineluttabili perché scritti nel DNA cinico, ossessivo, materialista, della nazione, ma che non si era ancora piegata al delirio ideologico degli ultimi anni, alla forma moderna dell’autoflagellazione post-Vietnam e al capriccio trasformato in diritto. Un’America che in buona parte, quella sufficiente a soddisfare le brame delle multinazionali e delle leghe sportive, cioé due volti della stessa medaglia, aveva i mezzi e lo spirito per godersi lo spettacolo dello sport e dei suoi esponenti migliori. Terreno minato, ovviamente, quello della società e della politica, sul quale ci sarebbe da scrivere un altro libro, se non fosse che la politica e le sue ramificazioni mi fanno ribrezzo. Sarebbe però divertente farlo, avendo io oltretutto studiato quella nazione e il suo sport dagli anni Settanta ed essendoci andato decine di volte non da turista ma da osservatore, prendendo i mezzi pubblici e restando tra la gente senza chiudermi in hotel a cinque stelle e in uffici di professori universitari. Sarebbe divertente farlo, dicevo, anche solo per contrapporlo alle narrazioni che dilagano, faziose, adolescenziali, ideologizzate e dunque perfette per portarne gli autori al successo, nel conformismo del sistema che domina i media.
Jordan è emerso dunque in un periodo storico particolare, gli anni Ottanta che lo stereotipo vuole edonisti ed egoisti, e l’ha dominato con la sua forza, la sua cattiveria agonistica, la sua indisponibilità a rallentare, anche quando ha (due volte) lasciato il basket giocato. Un atleta di un’età, appunto, in cui tenacia e capacità di scavalcare gli ostacoli posti dal destino avevano un valore assoluto, un periodo in cui mai e poi mai una rivista di grande nome avrebbe nominato Atleta dell’anno una persona che si era ritirata da quasi tutte le finali olimpiche, come è accaduto nel 2021 con Time e la ginnasta Simone Biles, la più grande della storia a sentire gli esperti e certamente – come tutte le ginnaste, pazzesche per quello che fanno – autrice di imprese strepitose. Sono doverosi la comprensione e il rispetto per la Biles, che come molte colleghe ha dovuto per anni, con pesanti conseguenze psicologiche, subire i soprusi e le violenze del famigerato medico della federazione di ginnastica, Larry Nassar, un criminale protetto dai titoli di studio e dall’omertà della struttura in cui lavorava. Ma l’elezione ad Atleta dell’anno, di cui la Biles non ha alcuna colpa, ha dato esattamente la misura della mentalità attuale di chi ha fatto tale scelta, la mentalità che non premia più la tenacia e la grinta ma la debolezza. E non per nulla Biles disse di essersi ispirata a Naomi Osaka, la tennista che si era ritirata dai tornei di Parigi e Wimbledon, poche settimane prima, perché sentiva il bisogno di staccare con la testa. Benissimo. Anzi, beato chi può permetterselo (io stesso lo avrei fatto più volte, se avessi potuto) e che va dunque lasciato libero di riprendersi e guarire: ma premiare addirittura un atteggiamento del genere vuol dire aprire le porte a una perenne celebrazione della sconfitta. Vuol dire un giustificazionismo permanente e superficiale che conduce – non a caso – a elogiare impulsivamente, di pancia, Giannis Antetokounmpo quando risponde piccato ad un giornalista che gli chiede se l’immediata eliminazione dai playoff 2023 dei Milwaukee Bucks, favoriti, non sia stata un fallimento. Certo che lo è stato, viste le premesse, e non c’è nulla di male a fallire: a me ad esempio è successo spesso, soprattutto negli ultimi anni, e ho cercato, pur brontolando, di incassare e andare avanti, anche per assenza di alternative. Si può perdere e si può fallire, è anzi l’eventualità più frequente, ma non per questo si deve essere premiati, e soprattutto conta quello che si fa, dopo il fallimento.
Il paradosso della contrapposizione tra l’età stoica in cui è emerso Jordan e un’età all’ammorbidente come quella attuale è che con la sua ossessione nel vedere sgarbi e nemici, detrattori e sabotatori ovunque, Jordan è però stato involontariamente il padre di questa cultura del vittimismo. Involontariamente, appunto, perché c’è una differenza enorme, decisiva: nel suo caso, allo sgarbo, vero o presunto che fosse, seguiva la reazione forte, cattiva, determinata di un uomo vero pur con tutti i suoi difetti, mentre la tendenza attuale non è quella di reagire moltiplicando le forze ma di piagnucolare e puntare il dito, riducendo questioni anche importanti ad un nero e bianco senza zone grigie su cui ragionare. Questo tsunami di vittimismo ha travolto e stravolto anche il senso stretto delle parole. Hai una perplessità, un dubbio, un fastidio, un’irritazione, hai quindi sfumature di percezioni che in quanto tali dovrebbero suscitare analisi e ragionamenti? Sei immediatamente un hater, uno che odia. E non per nulla, in un mondo che copia pari pari le espressioni americane senza interrogarsi sui dettagli e sulle circostanze, anche da noi da qualche anno diventa ‘odio’ anche la semplice espressione di critica, anche cortese, su quanto fatto o detto da altri. E questa tendenza al vittimismo, magistralmente criticata addirittura nel 1993 da Robert Hughes nel suo La cultura del piagnisteo, in cui venivano smantellate nella loro ipocrisia e ignoranza le prime manifestazioni del politicamente corretto e si sottolineava la loro inutilità nella lotta concreta alle vere discriminazioni, ha avuto conseguenze drammatiche nella società attuale, in cui i media prendono immediatamente le parti di chi si sente ‘odiato’ senza chiedersi in cosa consista quel presunto odio. Ecco, giusto per non uscire troppo dal tema, il concetto da ribadire: Jordan, nella sua ferocia vendicativa contro chiunque avesse anche solo espresso un dubbio su di lui, è involontariamente diventato capostipite di un mondo che però reagisce in maniera opposta alla sua, piagnucolando e non facendosi forza.
L’età di Jordan è stata eroica anche per coincidenze tecnologiche e mediatiche. Dal 7 settembre 1979 alle reti televisive tradizionali si era aggiunta la ESPN, unica a trasmettere solo sport, che poco alla volta, con una formula innovativa, aveva trovato spazio, inserzionisti, voci, diritti, eventi. ESPN nacque come tv via cavo, un sistema che in America ha avuto il sopravvento per decenni e che va spiegato. Le tradizionali reti commerciali gratuite, ovvero ABC, NBC, CBS, erano diffuse via etere, quindi ricevibili con una semplice antenna, ma la vastità e la conformazione del territorio, comprendente enormi aree poco popolate o remote, rendeva impossibile una diffusione con i metodi tradizionali, per cui il loro segnale era catturato via satellite da agenzie e distribuito da ripetitori nelle zone adiacenti, dunque con qualità soddisfacente. Tali agenzie costituivano normalmente anche le cosiddette ‘affiliate’, cioé occupavano una parte del palinsesto con programmi e pubblicità locali. Per fare un esempio, un abitante di Aberdeen, South Dakota, vedeva i programmi nazionali della ABC nell’80% circa del tempo, mentre il rimanente 20% era occupato da programmi locali come notiziari che generalmente precedevano quelli nazionali. Poco alla volta le varie agenzie cominciarono ad offrire ai clienti questi canali anche via cavo, aggiungendo al pacchetto nuove emittenti a pagamento, tra cui appunto ESPN, che all’inizio ebbe solo 1,4 milioni di abbonati. La prima frase che quegli abbonati sentirono la pronunciò, quel 7 settembre 1979, Lee Leonard, un giornalista già di buona carriera: «Se sei un appassionato di sport, quello che vedrai nei prossimi minuti, ore, giorni potrebbe convincerti di essere finito in Paradiso». Leonard poi passò la parola al collega George Grande e quello fu l’inizio di ESPN e di Sportscenter, il notiziario serale che per almeno tre decenni ha rappresentato il concentrato della diffusione televisiva dello sport. Passato sotto vari formati e progressivamente allargatosi anche ad altri orari, Sportscenter chiudeva la giornata sportiva mandando in onda rapide sintesi delle partite dei vari sport, alcune delle quali ancora in corso magari sulla costa ovest, e presto cominciò a proporre la rassegna delle 10 migliori azioni. Per anni e anni finire nella Top Ten di ESPN voleva dire raggiungere, anche solo brevemente, la popolarità: senza volerlo Sportscenter anticipava quello che si ritiene comunemente e forse superficialmente essere l’atteggiamento dell’utente televisivo moderno, anzi dell’utente da social media, cioé la scarsa capacità di fare attenzione per lunghi periodi e la predisposizione a contenuti rapidi e spettacolari.
Jordan ha unito anche questi due mondi, quello dell’attenzione costante e quello della concentrazione intermittente: le sue partite andavano guardate per intero, per poter cogliere l’evoluzione e l’epifania delle sue doti, ma potevano bastare anche le azioni da Top Ten, principalmente schiacciate, che innalzarono l’arte già resa famosa, qualche anno prima di lui, da Julius Erving, Doctor J, al quale all’inizio venne accostato e contrapposto. Perché Erving, ala piccola, nato nel 1950, stella della ABA e poi della NBA, era stato quello che aveva elevato la schiacciata a forma di espressione artistico-agonistica: non era stato il primo esterno ad eseguirla, togliendola al monopolio di centri e ali forti, ma il primo a renderla una forma di comunicazione, delicata anche quando violenta e aggressiva. Curioso, peraltro, il destino di Erving: passato da sottovalutato a sopravvalutato, per via di un tiro da fuori non affidabile, poi ancora a sottovalutato, oggi, quando praticamente nessuno lo colloca tra i più forti giocatori della storia. Eppure è stato un artista, una delle più belle, libere e spettacolari espressioni di quella creatività afroamericana che aveva trovato il contesto migliore nella ABA, nata nel 1967 per contrapporsi alla NBA. Fateci caso: nel 1973, periodo in cui la ABA stessa stava trovando la maturità pur con parecchi disagi, nasceva un’altra forma espressiva nuova, l’hip-hop. O perlomeno nasceva ufficialmente con la data fissata all’11 agosto, serata in cui un deejay di origine giamaicana, Clive Campbell detto DJ Kool Herc, abbreviativo di Hercules, soprannome che gli era stato dato per la sua statura e la sua potenza proprio sui campetti di basket, fece il deejay ad una festa organizzata dalla sorella, che voleva, con l’incasso, permettersi qualche abito nuovo da indossare all’imminente ripresa delle lezioni al liceo. Come scrive Nelson George nel suo magistrale Hip Hop America, nel periodo in cui la NBA e soprattutto la NCAA, la struttura che regola lo sport universitario, sembravano intente a soffocare la creatività, nella ABA veniva fuori una serie di talenti afroamericani che non si poneva limiti nell’estetica personale, ad esempio con la famosa capigliatura afro esibita anche da Erving, e in quella stilistica, con polsini, fasce elastiche per la testa, tubolari volutamente ostentati. E se nel rap predominava il sampling, ovvero l’utilizzo in brani originali di pezzetti di canzoni già note, nel basket l’esercizio liberatorio dell’estro, che trovò sfogo pieno in Jordan, si esercitava anche con il sampling di abilità altrui: e allora il ragazzino cominciò a copiare Michael per il suo polsino all’avambraccio, Iverson per il palleggio in crossover, Kobe Bryant per la Mamba Mentality, fortunatissima creazione di marketing diventata un marchio di fabbrica e sogno per illusi, dato che anche Kobe è stato unico e qualsiasi pretesa di imitarlo è stata una sorta di inganno fatto a se stessi.
Respiriamo un po’, ora, io e voi. Con una informazione di servizio, un’avvertenza: questo libro procede con una successione narrativa che è solo parzialmente cronologica, e si concentra con molto dettaglio sul periodo della formazione, quello in cui tutto si costruisce. Seguiremo Jordan dall’infanzia alla vittoria del terzo titolo nel 1993, per poi esaminare e raccontare il mondo commerciale e quello personale nel quale vive ormai da quel 1984, anno del contratto con la Nike che ha cambiato la sua vita e quella di decine di migliaia di persone. Poi riprenderemo il percorso cronologico, dal tentativo di giocare a baseball alla cessione dei Charlotte Hornets, estate del 2023. Ho cercato di movimentare così, per non ridurre il racconto ad una semplice successione di eventi, specialmente sul parquet, che per il periodo NBA sarebbe stata tremendamente noiosa già da scrivere, figuriamoci da leggere. Libri su Jordan del resto ce ne sono tanti, molti sono splendidi e alcuni sono stati anche tradotti in italiano, ma come faccio sempre quando scrivo ho cercato di leggere e interpretare la realtà aggiungendo elementi che al lettore americano non interessano o non sembrano necessari, mentre lo sono per il lettore di un’altra nazione. Un americano sa cosa voglia dire, a grandi linee, crescere nel sud degli Stati Uniti, e questa caratterizzazione geografica e sociale è quella che spesso manca nella descrizione di personaggi ed eventi di quel paese, così come manca in racconti di giornalisti o scrittori stranieri sull’Italia, talvolta imbarazzanti anche perché imboccati da colleghi italiani decisi a proiettare un’immagine (in genere negativa) piuttosto che un’altra. Noi italiani, sentendo parlare un palermitano e un friulano, ci rendiamo conto istintivamente del diverso ambiente in cui sono cresciuti, della diversa prospettiva anche a parità di cultura e classe sociale, mentre tutto questo troppo spesso viene sorvolato nelle narrazioni di altre nazioni. Nei miei limiti di spazio e di intelletto ho cercato quindi di raccontare Jordan tenendo conto di tutti gli elementi inconsapevolmente facili per uno statunitense ma un po’ meno per noi.
E ho cercato, come sempre, di non fidarmi troppo di quello che è stato raccontato e narrato, di non prendere sempre le parti che l’opinione pubblica prende, spesso per conformismo, superficialità e mancanza di conoscenza. Del resto, come ho scritto, sono stato in America decine di volte, e solo un paio da turista: negli altri casi, inviato da American Superbasket, la rivista in cui ho lavorato dal 1994 al 2009, e molto più spesso a mie spese, ho viaggiato proprio per studiare meglio sport, cultura popolare e società, così da poter raccontare tutto senza pareti e suddivisioni. Spero, ovviamente, che il risultato piaccia.
(Introduzione del libro ‘L’età di Michael Jordan’, di Roberto Gotta, pubblicato da Indiscreto nel giugno 2024 e in vendita su Amazon, sia in versione cartacea sia in versione Kindle, sulle altre librerie online e in tante librerie fisiche in tutta Italia, dalla Hoepli a chiunque ne abbia fatto richiesta al nostro distibutore, Distribook).
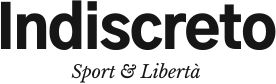
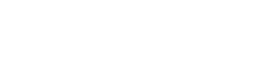

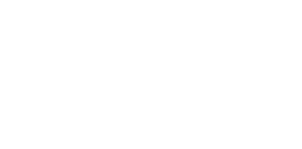
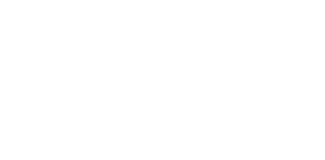
Commenti Recenti